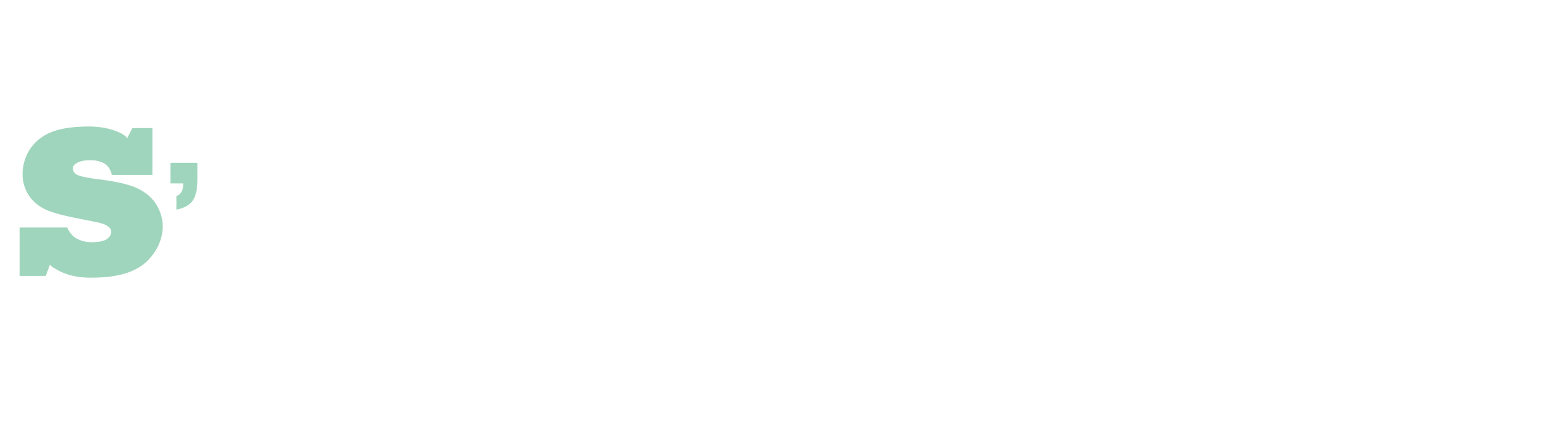Settimana Gramsciana, tra liberazione, su connotu e Sa Die
Il 27 aprile si ricorda la morte di Antonio Gramsci (27 aprile 1937). Una data singolare, incastrata com’è tra il 25 (festa della liberazione italiana dal nazifascismo) e il 28, Die de sa Sardigna. A cui aggiungerei il 26, giornata in cui ricorre l’anniversario dei moti “de su connotu” di Nuoro (1868). A Nino Gramsci non sarebbe dispiaciuto essere associato a queste ricorrenze, sia pure nella data in cui si ricorda la sua morte. Morte dovuta alla sua salute precaria, aggravatasi negli undici anni di detenzione cui l’aveva condannato il fascismo. Nonostante le aspettative del procuratore che aveva emesso la condanna, il cervello di Gramsci non smise di funzionare, se non proprio negli ultimi tempi della sua prigionia. Il regime dispose di farlo uscire dal carcere quando era pressoché in fin di vita, come se questo bastasse ad attenuarne la responsabilità. E Gramsci morì col suo biglietto di sola andata per la Sardegna, con i parenti che lo aspettavano per accompagnarlo nella residenza di Santu Lussurgiu allestita per lui, secondo le sue stesse volontà.
Come sottolineava il grande storico Eric Hobsbawm nel suo ricordo del 2007 in occasione del settantesimo anniversario della morte (il video è disponibile in rete), è difficile comprender fino in fondo il patrimonio teorico e la testimonianza ideale di Gramsci se si prescinde dal fatto che fosse sardo. Eppure questa condizione è stata sempre elusa dalla narrazione italiana sul suo conto. Gramsci, ridotto a “un cencio inamidato” proprio da quella che doveva essere la sua parte politica, a santino da venerare, a “fondatore del partito comunista italiano” e basta, a dispetto della mole di studi che lo riguardavano in tutto il mondo. Nemmeno la fama internazionale, soprattutto successiva alla pubblicazione integrale e filologica dei suoi quaderni e della sua corrispondenza dal carcere, nel corso degli anni Settanta del secolo scorso, ha scalfito la cornice ristretta e il ritratto opaco a cui è stata ridotta la sua figura in Italia.
Non possiamo neppure dire che almeno in Sardegna il patrimonio di elaborazione che ci ha lasciato sia stato sfruttato in modo fecondo. La sinistra sarda, succursale coloniale di quella italiana, ha a lungo evitato di rivendicare l’eredità gramsciana e di farne una cassetta degli attrezzi buona per cercare di capire e poi affrontare i disastri della nostra storia recente.
Solo in questi ultimi anni, grazie al lavoro di pochissime persone e alle pubblicazioni di due studiosi come Cristiano Sabino e Gianni Fresu, è possibile vederci restituito un Gramsci finalmente integro, non scisso, né menomato. Un Gramsci sardo e internazionalista, pensatore e leader politico, fine analista e militante con i piedi ben piantati sul terreno della realtà.
Ammettere che la rilevanza di Gramsci negli studi postcoloniali e in quelli sulla subalternità (ricordando che il concetto di “subalterni” è proprio gramsciano) discenda dalla sua origine e appartenenza sarda (mai rinnegate) significa ammettere che la questione sarda è anche e soprattutto una questione coloniale. Ma questo è un tabù, nell’ambito accademico sardo e in quello politico e mediatico. A maggior ragione tale aspetto va fatto emergere.
Certo, non va nemmeno fatto l’errore opposto e speculare, ossia quello di ridurre Gramsci a una sorta di icona indipendentista. Sarebbe comunque una forzatura indebita. Eppure non sarebbe un torto così grave come quello che gli si è fatto a lungo nel considerarlo del tutto disinteressato alle sorti dell’isola, anzi sbocciato politicamente solo in virtù del suo allontanamento e del suo soggiorno torinese. Come se Gramsci, prima del 1911, fosse stato uno spaesato giovane squattrinato di paese, senza coscienza politica, senza alcuna connessione con la realtà sociale e culturale che lo circondava.
Ricordiamolo, dunque, in questi giorni di ricorrenze emancipative, sempre poco amate dal Potere. Ricordiamolo, leggiamolo, studiamolo, lasciamoci sfidare dalla sua lucidità di pensiero e dalla sua potenza concettuale. Senza farne una fonte di dogmatiche prescrittive, cosa che lui stesso avrebbe contestato, ma evocandone il lascito ideale come strumento di analisi e seme fecondo di ulteriori avanzamenti teorici e politici. Sappiamo quanto ce ne sia bisogno.
Immagine: fondazionedisardegna.it