
Sardegna e sguardo altro
Quasi sempre chi visita la Sardegna lo fa aspettandosi delle cose: cerca gli scorci da cartolina, la vita lenta di abitanti che nel loro immaginario vanno al mare tutto l’anno; si aspetta di assistere a sagre e feste in cui vedere gente in costume sardo, si stupisce di fronte alle situazioni in cui le persone ballano spontaneamente sulle note della musica tradizionale.
Non sempre ci si interroga sulle dinamiche che portano a trasformare la cultura in intrattenimento o sulla sovrapposizione dei concetti di valorizzazione e prodotti di consumo.
Ad esempio molte persone, sarde e non, pensano sia un “diritto” vedere le maschere dei carnevali tradizionali sfilare d’estate in qualsiasi località di mare, senza che nulla di ciò che vedono abbia un collegamento con il contesto a cui appartengono i riti e i simboli evocati; senza avere i codici per capire cosa stia succedendo. Ma è davvero così? Si può davvero parlare di “diritto” in merito alle aspettative di assistere a una sorta di “parco giochi delle cose di Sardegna”, come trasposizione semplificata di elementi di una cultura complessa?
Quella con i luoghi è una delle relazioni maggiormente sottovalutate.
Saper “stare” in un contesto non è scontato: non ci si sofferma abbastanza a riflettere su come occupiamo gli spazi. Lo facciamo non solo coi nostri corpi, ma anche con le nostre voci, con le nostre abitudini, con i nostri comportamenti.
Quando si viaggia spesso si considera la fruizione, un diritto. Il riposo è un diritto, viaggiare per diletto è una forma di privilegio.
Saperlo implica la responsabilità di occupare gli spazi in cui ci si reca, con un rispetto che va al di là dell’aspetto materiale.
Fruire dei luoghi è una facoltà che va esercitata con consapevolezza.
Capita in Sardegna di sentir parlare di “valorizzazione” del patrimonio culturale, materiale e immateriale, in contesti in cui si “mette in scena” la sardità, con tutti gli elementi considerati rappresentativi (riti, tradizioni, antichi mestieri, abiti tradizionali, cibi): in questi contesti, tutto ciò che si considera “tradizionale” viene trasformato in prodotto di consumo. Di fatto si “vende” un’idea di Sardegna stereotipata a scopo intrattenitivo.
Così facendo non solo si contribuisce a consolidare un immaginario separato dalla realtà, ma si contribuisce anche a soddisfare lo sguardo esterno, le aspettative che una certa idea di Sardegna venga presentata per non deludere chi la “visita”. Il problema è che quello sguardo lo abbiamo anche assimilato.
Quale sguardo?
Oggetto di una narrazione pervasiva e longeva, la Sardegna è diventata, nell’immaginario collettivo, una specie di non-luogo narrativo, la cui cultura è spesso sintetizzata in chiave intrattenitiva attraverso rappresentazioni univoche (gli abiti tradizionali, le maschere, il matriarcato, il pastore, il bandito, l’orgoglio, la Barbagia eccetera).
La Sardegna, in questo immaginario, è al centro di un racconto in cui la narrativa è più forte della realtà stessa.
Da dove nasce questa narrazione?
È stata la letteratura di viaggio ottocentesca e dei primi del Novecento a fondare il mito della Sardegna come terra esotica, ignota, da scoprire. Il concetto di viaggio si è evoluto secondo connotazioni diverse a seconda del motivo e del contesto: in passato si viaggiava per motivi religiosi (pellegrinaggi), per motivi militari o politici (spedizioni, guerre, espansione coloniale).
Il “turismo”, come lo conosciamo oggi è una pratica che nacque nell’Ottocento come derivazione di una pratica di stampo colonialista e classista.
Il viaggio come svago era riservato alle classi privilegiate: nell’Ottocento l’Europa è considerata come il centro del mondo, depositaria di valori morali, della civiltà e del progresso. Si stabilisce una gerarchia tra culture evolute e culture “arretrate” da “far evolvere” (questa idea ha giustificato secoli di saccheggi e oppressioni).
Nell’Ottocento il viaggio assume la valenza di ricerca dell’esotico, un tratto tipico del Romanticismo europeo.
I viaggiatori dell’Ottocento esplorano e descrivono il mondo con quel retroterra culturale. Quando descrivono ciò che vedono altrove, sono influenzati dai principi della cultura dominante della quale sono esponenti privilegiati.Nel momento in cui visitano altri paesi e decidono di fare un resoconto del loro viaggio, lo fanno con un pensiero coloniale, con una prospettiva già distorta e condizionata da pregiudizi.
Basta fare riferimento alla strumentalizzazione delle teorie evoluzionistiche con l’obiettivo di gerarchizzare le culture, per comprendere come l’Occidente “evoluto” guardi “il resto del mondo”. Da questo retroterra vengono l’interesse morboso per l’esotico (freak show) e lo schiavismo, come deriva della convinzione di potersi recare ovunque con la certezza di possedere le risorse, le persone, l’ambiente.
In quest’ottica, l’obiettivo del resoconto di viaggio è riportare all’esterno il senso dell’esotico, il fascino del selvaggio, lo sguardo paternalista del civilizzatore per il quale non è tanto importante comprendere o documentare la realtà, quanto soddisfare la propria curiosità verso il peculiare, il pittoresco.
La Sardegna si prestava perfettamente a questa esigenza narrativa: era (ed è) poco nota, “selvaggia”, “esotica”: le sue tradizioni colpivano per la loro particolarità. E ad un’osservazione superficiale, senza i codici per decifrarle, possono risultare ancora tali.
La descrizione che ne risulta non dice tanto sulla cultura sarda: manifesta più la prospettiva di chi la produce, in cui non è importante che quanto viene rappresentato sia vero. È invece molto importante che il desiderio di scoperta e la ricerca del pittoresco siano soddisfatti.
La verità di chi gestisce la narrazione, e chi parla di Sardegna spesso lo fa da una posizione di potere e privilegio, conta più della realtà stessa.
Su questo sistema narrativo si fondano interi sistemi economici, di cui fa parte anche il turismo, un turismo di massa, basato sull’idea che possa essere “utile” o “salvifico” perché crea posti di lavoro, produce ricchezza.
Una ricchezza illusoria, le cui ricadute si estendono ben oltre la Sardegna, che subisce i danni del turismo di massa, del saccheggio delle risorse senza che le comunità vengano risarcite.
Ed è così che lo sguardo e l’intervento altrui vengono propagandati e interiorizzati come portatori di “progresso”.
È lo sguardo “salvifico” del colonizzatore, l’unico che può risolvere l’arretratezza, intesa come caratteristica innata, come se fosse un precipitato storico da accettare passivamente e non il risultato di un sistematico sfruttamento delle risorse locali e dell’imposizione più o meno coercitiva, di modelli culturali esterni, veicolati come migliorativi di una condizione considerata “inferiore”, “minoritaria”.
È attraverso la consapevolezza di queste dinamiche che sarà possibile tornare a essere comunità narrante nel rispetto della complessità che caratterizza il contesto culturale della Sardegna.
Immagine: ylanite-koppens tramite pexels
Un commento
Lascia un commento / Cummenta
I commenti saranno sottoposti ad approvazione prima della pubblicazione.
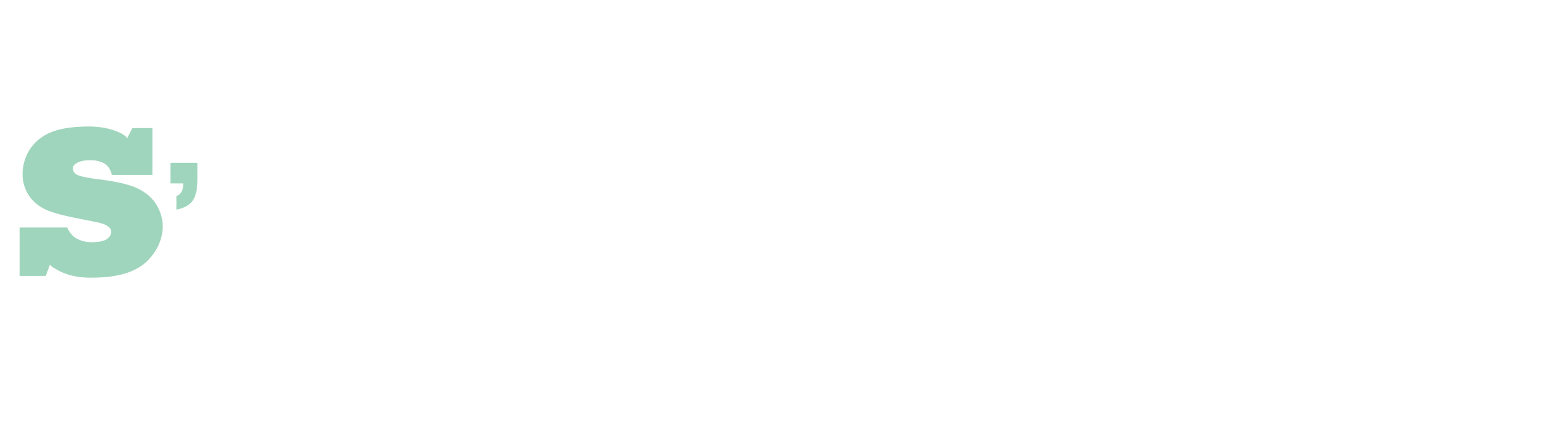





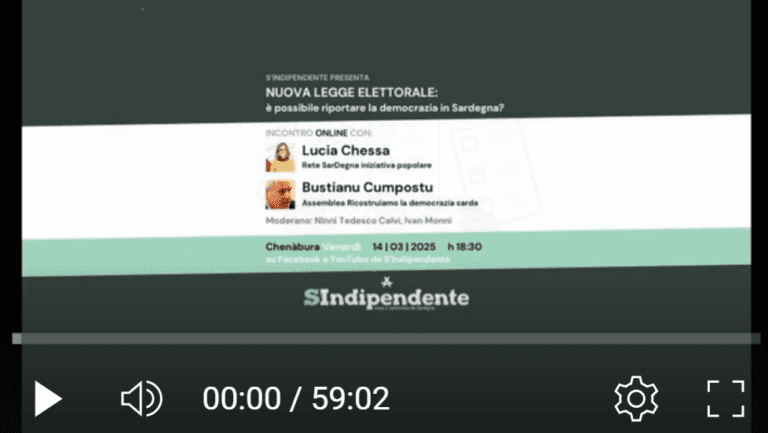










[…] primitivista della Sardegna, realtà poco conosciuta a chi la abita, figuriamoci a chi ne sta fuori.È un’idea longeva di stampo colonialista e razzista che si rintraccia nei resoconti di viaggio ot…Quando gli usi e costumi sardi fuoriescono dallo spazio in cui sono legittimati, ovvero non […]