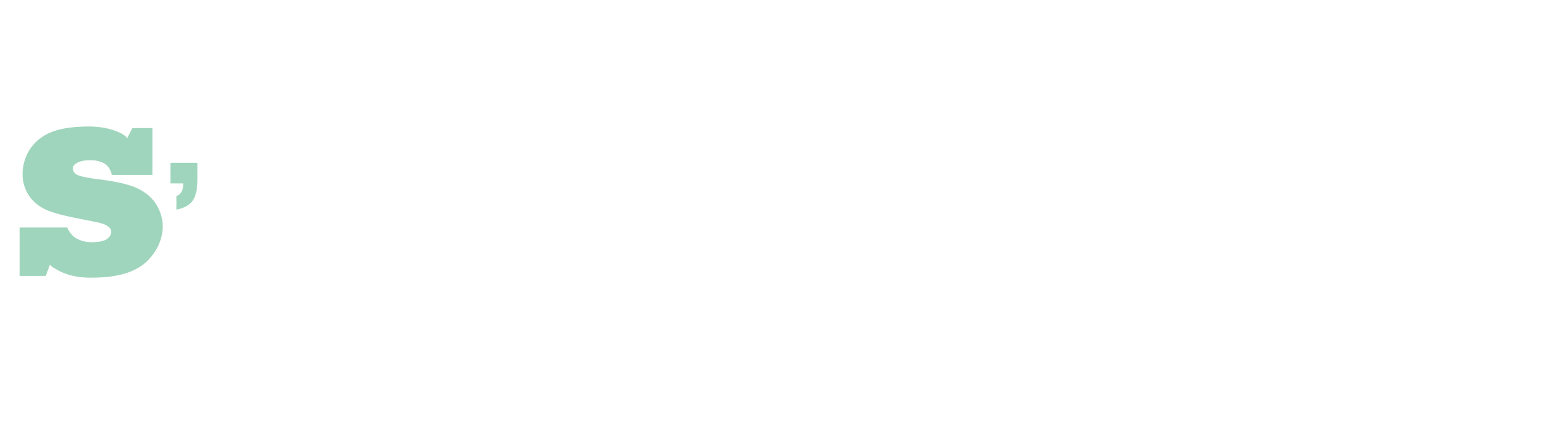Pregiudizi e luoghi comuni sulla Rivoluzione sarda e Sa Die de sa Sardigna
Il periodo rivoluzionario sardo, evocato con la festività di Sa Die de sa Sardigna, ha sempre goduto di cattiva stampa e di scarsa considerazione da parte del mondo accademico. Anche la politica lo ama pochissimo, compresa una parte dell’ambiente indipendentista. Per sminuirne significato e portata si è ricorso a una serie di argomentazioni che di tanto in tanto riemergono nel dibattito pubblico (purtroppo evanescente e di bassa qualità). Vediamone alcune, le principali, e proviamo a valutarne la pertinenza e la correttezza.
Il periodo rivoluzionario non fu una vera rivoluzione ma una forma di restaurazione guidata da una parte retriva dell’aristocrazia sarda
Questa obiezione arriva anche da ambienti accademici. Il che è sorprendente, dato che fa torto sia agli eventi così come accaddero, sia più in generale ai processi storici (non solo sardi) di quel decisivo periodo. L’autoconvocazione del braccio aristocratico del parlamento sardo (lo stamento militare), nel gennaio 1793, cui seguirono quelle degli altri due bracci, è del tutto assimilabile alla convocazione degli Stati generali in Francia nel 1789. Per la Sardegna si trattava di difendersi da un attacco militare, per la Francia si trattava di discutere il riassesto delle finanze del regno: momenti di emergenza diversi, ma che richiamavano la necessità di contrapporre all’assolutismo monarchico una forma di decisione politica negoziata con le componenti sociali. Il ricorso a forme derivate da ordinamenti antichi, di origine feudale, era calato in un contesto del tutto nuovo, in cui circolavano da molti anni idee di riforma politica e di progresso che si erano fatte largo negli strati sociali istruiti e in quella che potremmo definire la classe politica. L’imporre al sovrano una decisione del genere, sia nel caso francese sia in quello sardo, costituiva di per sé già una rottura di un ordine che le monarchie del tempo davano ormai per assodato. Per quanto apparissero come tentativi di ritornare al passato, di recuperare al ceto aristocratico un potere perduto, erano invece le prime crepe nella diga assolutista. Come tali, premesse lineari degli eventi successivi. Guardare alla convocazione degli stamenti sardi come a un fatto isolato e ridotto al suo senso letterale, senza contestualizzarlo e collegarlo a tutto ciò che si muoveva intorno e che ne emerse poi, è un errore di interpretazione anche piuttosto grossolano. Senza considerare che nella stessa classe dirigente sarda di quegli anni erano già operanti forze nuove e prospettive di avanzamento politico che aspettavano solo l’occasione per dispiegarsi. Come infatti avvenne.
Il tentativo rivoluzionario sardo fu un fatto elitario, che riguardò una porzione minima della popolazione sarda
Quando emerge un sommovimento politico di proporzioni epocali come quello degli anni 1793-1812 vuol dire che un nodo storico stava venendo al pettine. Le forze sociali e intellettuali che presero la scena dalla convocazione degli stamenti in poi erano uno dei fattori in campo, non l’unico. I sommovimenti delle campagne e dei villaggi infeudati, il malcontento dei ceti produttivi e della nascente borghesia rurale e urbana, il fastidio generalizzato verso l’amministrazione sabauda non erano fenomeni superficiali e contingenti. Per questo le azioni e le prese di posizione dei ceti dirigenti sardi assunsero presto il loro colore dirompente dell’ordine costituito e si saldarono, a volte in modo contraddittorio, altre volte in modo consonante, con le aspettative crescenti delle popolazioni cittadine e di quelle delle campagne. Tant’è che qualsiasi tentativo di ridurre la sfida politica a una dialettica istituzionale tra classe dirigente sarda e amministrazione sabauda fu pressoché subito superato dagli eventi. Non c’era nulla di elitario e ristretto a circoli minoritari nelle sedute degli stamenti o della Reale Udienza a cui prestavano orecchio folle di popolani, pronte a manifestare consenso o dissenso. Non c’era nulla di elitario nelle mobilitazioni contadine che presero la scena nella campagne, costringendo spesso sulla difensiva la classe baronale. Il numero di persone coinvolte nelle vicende del periodo rivoluzionario sardo è così elevato e trasversale, sia in termini sociali sia anagrafici sia territoriali, da legittimare la definizione di un vero e proprio fenomeno di massa.
Anche le punte più avanzate del movimento rivoluzionario sardo erano in realtà su posizioni molto moderate e non erano chiari i loro obiettivi
Un frangente storico come quello, allo stesso modo della Rivoluzione francese, porta in sé contraddizioni e dinamiche conflittuali. Smuovere tutt’a un tratto un’inerzia storica come quella dell’Ancien Régime implica lo scatenarsi di forze collettive e di aspettative di vario genere e intensità. Che gli obiettivi delle personalità e dei gruppi coinvolti non fossero sempre del tutto coincidenti è perfettamente normale, proprio perché si trattò di circostanze che coinvolgevano pressoché l’intera popolazione. La spaccatura all’interno dello stesso “partito stamentario”, ossia della compagine che aveva promosso il conflitto col viceré Balbiano, redatto le Cinque domande e allestito la delegazione che doveva presentarle al re, emerse quando i giochi politici fecero un salto di qualità e divenne chiara la portata della rottura politica in corso. Dai documenti dell’epoca, sia quelli più noti, sia quelli che emergono dalle ricerche più recenti, si evince che la fazione propriamente rivoluzionaria, quella a volte definita – con una certa approssimazione – degli “angioiani”, aveva un programma politico preciso e dettagliato. La sola lettura del manifesto intitolato L’Achille della sarda liberazione (probabilmente del 1795 o dei primi del 1796) offre una sintesi estremamente chiara delle premesse teoriche e degli obiettivi di questa parte. I contenuti di questo documento erano molto avanzati, tanto che avrebbero scandalizzato i convenuti al Congresso di Vienna, una ventina d’anni più tardi, e sarebbero suonati del tutto attuali nel 1848. Se letto in parallelo con l’inno Su patriota sardu a sos feudatàrios (rivolto al popolo, quindi scritto in sardo, in ottave di ottonari, da cantare a gosos), toglie ogni dubbio sui proponimenti del partito “novatore” e sul senso che i suoi aderenti davano alle proprie azioni. Non c’era nulla di moderato o di conciliante, in quello che dichiaravano e che facevano, come del resto risultò presto chiaro anche all’amministrazione sabauda e alla corte stessa. Era materia per cui si poteva finire sulla forca o essere costretti all’esilio e comunque perdere tutto, come successe a molti esponenti di quel partito, Giovanni Maria Angioy in primis.
Le mobilitazioni popolari erano ridotte e non avevano scopi politici definiti
Un tratto peculiare di quel periodo storico fu la saldatura tra diverse anime politiche. I gruppi intellettuali che concepirono il rovesciamento dell’ordine feudale e della monarchia assoluta non restarono chiusi nella propria bolla sociale, ma trovarono il modo di connettersi sia alle istanze popolari delle città, sia a quelle delle campagne. Molti protagonisti di quegli anni appartenevano ai ceti di vertice della gerarchia sociale, ma si prestarono a un ruolo di intermediazione e di guida teorica e politica delle masse. Il proponimento – esplicito nei documenti che abbiamo a disposizione, specie quelli redatti in esilio – era di saldare compiutamente in un grande disegno di rigenerazione complessiva le istanze che emergevano tanto nelle realtà urbane quanto nelle campagne vessate dal regime feudale. Lo scopo di abbattimento del regime feudale era dichiarato. Negli stessi patti tra villaggi è posto come obiettivo principale. Non ci sono dubbi, in proposito. Il gruppo dirigente del partito rivoluzionario era consapevole della complessità della situazione e della difficoltà di far accogliere alle masse un rovesciamento politico così radicale. Angioy chiarisce puntualmente nelle sue memorie destinate al governo francese i sicuri problemi a cui si sarebbe andati incontro imponendo alle popolazioni misure politiche troppo distanti dalle loro aspettative e dalle loro consuetudini. Da tutto questo traspare l’enorme sforzo di elaborazione, non solo teorica ma anche pragmatica, che si sobbarcò la leadership del partito rivoluzionario, ivi compreso il lavoro di persuasione e coinvolgimento delle masse, tutt’altro che passive e silenti nei vari frangenti dell’intera vicenda.
L’inno sardo Su patriotu sardu a sos feudatàrios non è un vero inno rivoluzionario, infatti comincia coi versi “Procurade ‘e moderare, barones, sa tirannia”
È una critica che viene fatta spesso. Diciamo subito che, quando fatta in buona fede, lascia intravvedere una scarsa conoscenza della lingua sarda e delle sue peculiari connotazioni semantiche. Non tiene nemmeno conto dell’intero componimento e della sua necessaria connessione tematica e programmatica con altri documenti del periodo, in primis col già citato L’Achille della sarda liberazione. Il primo verso dell’inno è in realtà una minaccia. Fatta nel modo ellittico, spesso antifrastico, tipico del sardo. Del resto, lo si evince da altri passaggi del poema, in cui si evoca apertamente lo scontro decisivo contro i barones (gherra!) e contro l’amministrazione piemontese. Su patriota sardu è al contempo un inno rivoluzionario e un catechismo politico e patriottico. Ha dei tratti di sorprendente modernità, tanto che alcuni versi si potrebbero adattare facilmente ai nostri tempi. I suoi contenuti erano dirompenti, tanto quando fu concepito, quanto negli anni successivi al periodo rivoluzionario, quelli della Restaurazione. È un documento preziosissimo sia in termini storici, sia in termini poetici, per la sua forza espressiva ancora oggi così coinvolgente.
Il periodo rivoluzionario sardo non ha rilevanza perché si trattò di fatti minimi, periferici e marginali rispetto alla vera Storia che intanto si dispiegava in Europa
Il tentativo di liquidare il periodo rivoluzionario sardo come marginale e insignificante si scontra con ciò che risulta da tutte le ricostruzioni storiografiche, a partire da quella del Manno, e con ciò che emerge dai documenti dell’epoca. Soprattutto le recenti scoperte di Adriana Valenti Sabouret hanno aperto uno squarcio di luce su una serie di relazioni e di collegamenti che molte personalità della rivoluzione sarda ebbero con i più alti livelli del governo francese e con le varie fasi della politica europea in epoca napoleonica. Alcune cose erano già note, a voler leggere le carte. Oggi il quadro si arricchisce di dettagli, mostrando l’intima connessione tra le vicende sarde e l’azione del governo francese, con riverberi nella politica di guerra delle altre potenze europee, tutt’altro che indifferenti alla sorte della Sardegna, per evidenti ragioni strategiche. La portata del periodo rivoluzionario sardo è molto maggiore rispetto ad altre vicende coeve, specie a quelle italiane, che però godono di molto più spazio nella manualistica storica e nella Grande narrazione pubblica mediatica e politica italiana. Certo, queste ultime possono più facilmente essere ricondotte dentro la cornice risorgimentalista. La rivoluzione sarda invece, nata da istanze e animata da forze locali, per ragioni specifiche dell’isola, per altro in contrapposizione all’amministrazione sabauda, mal si presta a un inquadramento nazionalista italiano. Per questo è più comodo, anche per la classe dirigente sarda, notoriamente poco incline della sfida al centro politico di riferimento (Roma), liquidarla come marginale e poco significativa.
Non ha senso ricordare e celebrare quel periodo, compresa la data del 28 aprile 1794, perché quel tentativo fu comunque sconfitto
La maggior parte delle rivoluzioni, da quella francese, a quelle del 1848, alla Comune di Parigi del 1871 e via elencando, sono state sconfitte. Non è mai stato un buon motivo per liquidarle come meritevoli di oblio e di scarsa considerazione. La portata degli eventi che si svolsero in Sardegna tra 1793 e 1812 fu tale che la stessa amministrazione sabauda ne conservò a lungo il ricordo, come un memento minaccioso, e ancora a distanza di un secolo suonavano vagamente preoccupanti per chi intendeva difendere l’ordine costituito. A lungo il periodo rivoluzionario sardo è stato poco indagato e soprattutto mal interpretato. Quasi sempre sminuendone senso e significato. Il fatto che ancora oggi sia così poco amato dalla classe dirigente sarda (politica, accademica, economica) dimostra quanto forti fossero le sue istanze e quanto senso politico abbiano avuto, al di là del fatto che la rivoluzione allora restò incompiuta, anche a causa del tradimento di una grossa parte del ceto dirigente sardo di allora, fin troppo simile a quello attuale.
È sbagliato annettere significati politici attuali al periodo rivoluzionario sardo
È sempre sbagliato usare politicamente la storia, soprattutto se si fa in termini di imposizione e di dominio, mistificando i fatti e il loro senso e rileggendo gli avvenimenti in modo anacronistico e propagandistico. Non è però un problema che attiene in particolare alla storia della rivoluzione sarda, evocata dalla festività del 28 aprile. Siamo immersi in un universo di segni e narrazioni che usano la storia per orientare il senso di appartenenza dell’opinione pubblica, dall’odonomastica (i nomi di vie e luoghi pubblici), alla narrazione dei mass media, al discorso politico dominante. Siamo invasi da intitolazioni viarie sabaude e risorgimentali, col paradosso di affiancare spesso personaggi che tra loro erano in cordiale disaccordo (pensiamo elle vie Cavour affiancate alle vie Mazzini, tanto per dire). In Sardegna siamo vincolati a una fedeltà sabauda a tratti ossessiva e sempre imbarazzante. I nostri centri abitati sono una celebrazione ostinata (e subalterna) di personaggi che con l’isola hanno avuto un rapporto come minimo complicato, se non proprio ostile. Nei libri usati nelle scuole sarde si insegna una storia estremamente orientata alla narrazione sciovinista italiana, in cui la Sardegna c’è poco e nulla, e quando c’è è menzionata in modo approssimativo e spesso del tutto scorretto. La storia sarda è pressoché ignota alla gran parte della popolazione dell’isola. Il problema dunque andrebbe posto decisamente su un altro piano. Ma, al di là di questo, c’è un altro aspetto della questione che non va ignorato. La rivoluzione sarda costituisce un momento di passaggio decisivo i cui effetti si allungano fin sul nostro presente. Al contrario di altre epoche, magari più celebrate, le sue vicende, i problemi sollevati allora, la natura dello scontro politico di quegli anni, gli effetti che ebbe la sconfitta del partito novatore e le scelte che la classe dirigente sarda fece in quei frangenti ci chiamano in causa pesantemente ancora oggi. Conoscere quel periodo, renderlo di dominio pubblico, patrimonio diffuso della cittadinanza sarda, è una necessità civile e democratica, senza bisogno di annettere a quei fatti significati politici ulteriori rispetto a quelli che ebbero allora. Ma se anche venissero usati politicamente per sostenere le istanze di cambiamento democratico attuali, non sarebbe certo un peccato così grave come quello commesso da chi, negando la nostra storia, o anche solo edulcorandola o ridicolizzandola, intende difendere lo status quo e mantenere la Sardegna in una condizione sempre meno accettabile di povertà, marginalità e subalternità.
Immagine: cittaturistica.it