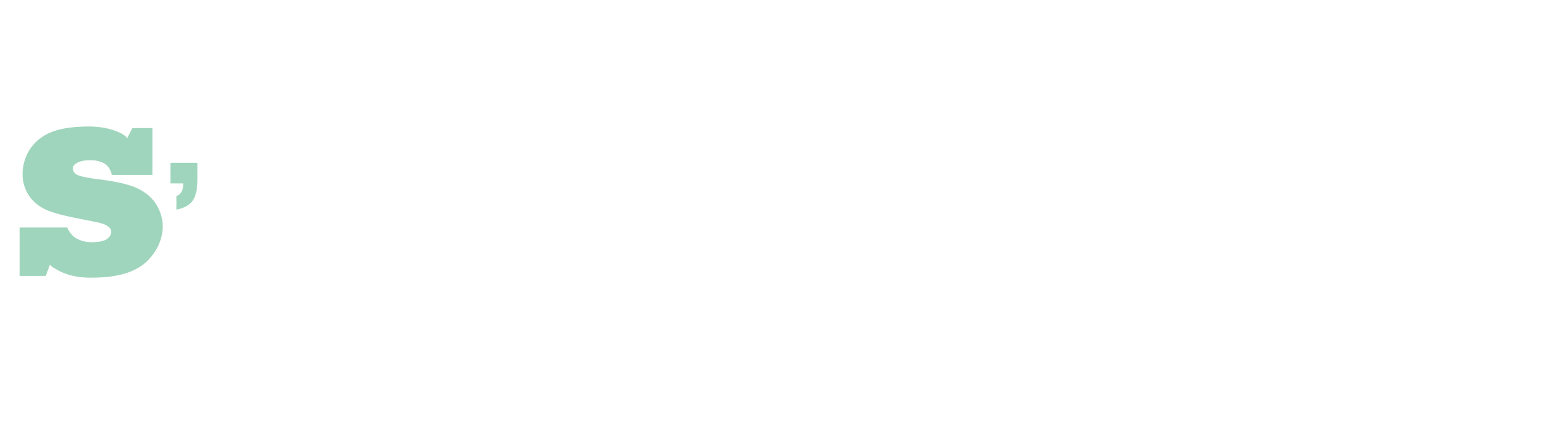Le donne della Sarda rivoluzione
Figure fondamentali della società sarda, le donne hanno sempre preso parte alla storia dell’Isola agendo al fianco degli uomini ma anche forgiando il destino della Sardegna, operando oculatamente e con saggia autorevolezza. L’esempio medievale più lampante è rappresentato dalla Giudicessa Eleonora d’Arborea che introdusse la Carta de Logu.
Occupandoci della Sarda rivoluzione, chi furono tali donne ? E in quale misura parteciparono al coraggioso movimento che scosse la Sardegna in un lasso di tempo compreso fra il 1793 e il 1812?
Poco ci è pervenuto dalla storia e forse le figure femminili citate non saranno state le uniche a contribuire alla causa dei moti antifeudali, ma poiché la ricerca storica deve fedelmente basarsi sui documenti, ce ne soddisferemo.
La donna che forse maggiormente contribuì alla causa della Sarda rivoluzione fu donna Marianna Serra, amica personale di Giovanni Maria Angioy e del lussurgese Michele Obino.
Figlia di don Vincenzo e sposa di don Gavino Serra, risiedeva a Ittiri e il suo ruolo era quello di mantenere il collegamento con i nuclei antifeudali attivi nelle zone limitrofe.
In una lettera al viceré datata 1° gennaio 1798, di lei scrive il giudice Giuseppe Valentino : «Detta donna non cessava di applaudire le massime ed operazioni di esso Angioy: fu l’unica Signora che venne dal medesimo visitata e che andò con esso lui al passeggio nei pubblici stradoni, senza aver rossore di propalare la prava sua opinione, con dire che era più vantaggioso a questo regno l’esser retto in Repubblica».
Sappiamo inoltre che, nell’ottobre del 1795, donna Marianna si reca da Sassari a Ittiri e successivamente a Santu Lussurgiu, a casa di don Michele Obino. Insieme a lui e ai fratelli Obino visita vari villaggi per fare propaganda antifeudale.
Nel 1797 la ritroviamo sospettata di progetti insurrezionali, tesi suffragata dalla sua fuga col Porcu Scolopio per sfuggire agli “orrori del massacro” come lei stessa affermò.
Il 3 gennaio del 1798, donna Marianna Serra riceve dal viceré l’ordine di recarsi a Sassari dove il giudice Valentino le imporrà ‘’gli arresti in casa’’.
Nel 1805, don Michele Obino, esule a Parigi, chiede sue notizie in una lettera alla madre, avendo sentito che Marianna si era recata in viaggio a Pisa “col prete arcivescovo”.
In seguito, ritroviamo le sue tracce, e quelle del marito, a Sassari e abbiamo nuovamente sue notizie nel 1811 quando, “venerata e riverita” dal governatore di Sassari, il Conte Revel, donna Marianna promette a Vincenzo Sulis, condannato per aver tramato contro la monarchia, di perorare la causa della sua libertà presso il re, in cambio di 1500 scudi. Sulis, tuttavia, non ne fa nulla, decidendo di evadere. Lo stesso, infatti, aveva già dato, invano, 500 scudi al nipote di Revel per essere scarcerato.
Questo è il poco che sappiamo su donna Marianna Serra, a parte le voci di corridoio che la volevano legata da una relazione più che amichevole con don Michele Obino.
Delle altre donne che satellitano più o meno attivamente attorno ai patrioti sardi sappiamo ancora meno ma vale la pena di ricordarle.
Donna Isabella Cugia coniugata con il visconte di Fluminimaggiore don Gavino Asquer Amat Manca, nasce a Messina ma risiede a Cagliari. Madre di undici figli, il 14 settembre del 1798 perora la causa del terzo di essi, don Francesco Maria, catturato dai tunisini a Carloforte nella notte fra il 2 e il 3 settembre.
La donna lamenta, in una lettera al viceré, l’ingiusto trattamento subìto dal figlio accusato ingiustamente da persone malevole che ne vogliono la rovina.
Gli ultimi giorni di vita della nobildonna saranno funestati dall’impossibilità di ottenere la liberazione del figlio dalla schiavitù, a causa delle notevoli perdite di beni sofferte da più di due anni. Muore in Castello il 16 aprile 1807.
Donna Giuseppa Delrio, detta Pepica, coniugata Rapallo, nasce a Sassari ma risiede a Cagliari nel quartiere della Marina. Vincenzo Sulis la cita nella sua Autobiografia definendola ‘’una Signora Dama’’. Il giudice Lavagna riferisce della loro ‘’amicizia’’ e delle manovre di Giovanni Mameli per separarli.
Donna Antonia Cherchi coniugata Massidda, di Santu Lussurgiu, nipote del sacerdote Diego Cherchi, vicario parrocchiale di Santu Lussurgiu, agli arresti nel seminario tridentino di Oristano per l’insurrezione del 5 ottobre 1800, con coraggio perora la causa dello zio. A tal scopo scrive a don Raimondo Quesada, reggente la Segreteria di Stato, per attestare l’innocenza dello zio. Il 10 aprile alcuni personaggi ottengono il rientro dall’esilio, tranne lo zio di donna Antonia.
Rosa Brigliano o Brillany, coniugata con l’avvocato Francesco Crobu, chiede, nel luglio del 1800, la grazia per il rimpatrio del figlio Emanuele Crobu, ex segretario di Giovanni Maria Angioy. La Brigliano afferma che questi non ha commesso alcuna azione criminale e che potrebbe esserle di aiuto nella difficile situazione in cui versa.
Di donna Maria Ignazia Cordiglia coniugata Solinas e, in seconde nozze, Guirisi, sappiamo che cedette in locazione un appartamento ad Angioy che il patriota s’impegnò a restaurare. Questi lo abitò durante il periodo di separazione dalla moglie Annica Belgrano. Il ‘’trait d’union’’ fra la donna e l’Angioy era il marito, don Antonio Guirisi di Fonni, giudice della Reale Udienza, come lo stesso Angioy.
Caterina Delogu coniugata Melis, nasce a Cagliari nel 1778 circa e risiede nel sobborgo di San Bernardo. Malata e probabilmente in stato di gravidanza, viene interrogata a casa per testimoniare sull’odio manifestato da Raimondo Nieddu nei confronti di Vincenzo Sulis. Dichiara di conoscere molto bene il Nieddu in quanto, essendo vicini di casa, sono cresciuti quasi insieme.
Maria Elena Piras, cuoca e cameriera residente a Cagliari dal 1794, era nata a Torralba. Lavora, in un primo tempo, al servizio dell’avvocato don Pasquale Atzori, membro dello Stamento reale. Dopo l’uccisione ‘’a maleficio’’ del generale delle armi, entrò in casa di Angioy fino a quando partì ‘’nella quaresima passata’’ per Sassari. All’inizio cameriera, poi soltanto cuoca, racconta che parecchie persone, fra cui Nicolò Angioy e Matteo Luigi Simon, pranzavano e cenavano da Angioy con molta frequenza, insieme a numerosi altri sassaresi di cui non conosceva i nomi. La donna, interrogata, rispose al giudice che Angioy non permetteva che i servi ascoltassero le loro conversazioni, e che ciò che si diceva fra i convitati non poteva essere udito da chi era nelle cucine, ubicate ‘’nel quartiere di sotto’’.
In tale excursus sulle figure femminili della Sarda rivoluzione, un posto a parte merita una donna bonese, Ambrogia Soddu.
Nel maggio del 1796, il viceré organizzò a Cagliari una commissione militare punitiva guidata da Efisio Pintor Sirigu, detto ‘’Pintoreddu’’, per sedare i villaggi in rivolta contro il feudalesimo, fra i quali Bono.
La spedizione giunse nei pressi di Bono il 18 luglio e i bonesi, considerata l’imponenza delle truppe, ripararono nella vicina montagna lasciando il villaggio vuoto. Solo una donna paralizzata, Ambrogia Soddu, fu lasciata nel suo letto anche pensando che i miliziani non avrebbero infierito contro una donna inerme. Ambrogia fu invece barbaramente uccisa, dopo averne saccheggiato la casa.
Insieme a lei occorre ricordare altre ‘’vittime’’ : le mogli e madri dei martiri della Sarda rivoluzione che patirono una vita di sofferenze e stenti perdendo, spesso atrocemente, i propri cari. A simbolo di tutte loro farei assurgere la moglie di Gioachino Mundula, Speranza Sisca De Peru che con lui ebbe tredici figli. Privata del marito, costretto a esiliarsi a Parigi dove morì senza più rivederla, vide il figlio Giuseppe ugualmente in esilio e il figlio Paolo agli arresti. Visse con dignità e difficoltà dovendo provvedere da sola ai figli minori.
Immagine: AI Dall-E