
Il declino della Sardegna e le responsabilità dei suoi ceti dirigenti
Qualche fermo immagine, giusto per introdurre il tema
Nel 2009, Ugo Cappellacci, allora Presidente della RAS, partecipava giulivo e grato, con tanto di badge da “invitato”, alla conferenza internazionale sulle autostrade del mare tra Spagna e Italia. Nell’isola della Maddalena. Ospite a casa sua. La Sardegna, per inciso, era esclusa dai grandi piani italiani del trasporto navale. Era lo stesso Ugo Cappellacci secondo il quale il problema della Sardegna “sono i sardi” e che era stato eletto letteralmente con la “mano in testa” di Berlusconi.
Del Pigliaru paracadutato nelle elezioni sarde da un atto di forza (obiettivamente indovinato) della segreteria romana del PD (a guida Renzi, allora) ci si ricorda meno, ma c’è stato anche lui. Christian Solinas entusiasta partecipante alle adunate della Lega è un’immagine che ha girato sui media, negli anni scorsi: difficile dimenticarsene, data la presenza in Sardegna per anni, al suo fianco, come consulente o controllore, del delegato coloniale Eugenio Zoffili. Qualche giorno fa, l’attuale Presidente della RAS, Alessandra Todde, esprimeva sincero giubilo per le vittorie del suo schieramento in Umbria e Emilia-Romagna e nell’ultimo fine settimana è intervenuta alla “costituente” del Mov. 5 stelle, di cui è elemento di spicco.
Cosa c’è di sbagliato o di brutto in queste immagini? Dipende da qual è la prospettiva in cui le inseriamo. Stiamo parlando dei massimi rappresentanti politici della Sardegna, depositari del mandato democratico a governare l’isola in nome e per conto dell’intera comunità sarda e nei suoi interessi. Almeno sulla carta. È lecito domandarsi a chi abbiano risposto delle loro azioni politiche le massime cariche istituzionali sarde nelle ultime quattro legislature regionali, compresa quella in corso.
Come siamo arrivati a questo punto?
Da che la Sardegna fa parte dello Stato italiano, siamo stati abituati a percepirci come una periferia, per giunta lontana e senza peso. Abbiamo interiorizzato la vergogna di essere una popolazione “arretrata”, “barbarica”, povera per proprie carenze congenite, con la conseguente necessità di essere integrati, dunque prima di tutto accettati, nel contesto della nazione italiana, portatrice di civiltà e “modernità”.
Le nostre élite sociali e culturali, che hanno sempre espresso la nostra classe politica, hanno avuto fin da subito il fondamentale obiettivo di ritagliarsi uno spazio, sia pure ancillare e “di servizio”, nella più vasta élite italiana. Il processo di parziale integrazione della nostra élite ha funzionato molto bene come ostacolo al formarsi in Sardegna di un ceto intellettuale e politico autonomo, non etero-riferito, non subalterno. Il colonialismo tramite integrazione delle élite della collettività colonizzata non è certo un’invenzione italiana ai danni della Sardegna. Già solo nel contesto italiano ha funzionato molto bene anche col Mezzogiorno del Paese. Lo Stato italiano ha dovuto fare concessioni rilevanti ai gruppi dominanti meridionali (cambiare tutto per non cambiare niente, come recita la famosa massima “gattopardesca”) e fare affidamento spesso anche sulla mafia, come agente sul terreno in moltissimi lavori sporchi. In definitiva, comunque, anche qui, una sorta di colonialismo interno tramite integrazione dei gruppi dominanti.
È successo anche altrove.
La stessa URSS si è retta su questo principio. Ma anche l’impero britannico ha spesso usato questo approccio. Così come la Francia. Le classi dirigenti locali che hanno guidato i processi di decolonizzazione e i ceti intellettuali che hanno fondato e animato il campo degli studi post-coloniali si sono formati nell’ambito culturale e presso le istituzioni accademiche dei paesi colonizzatori. Insomma, la Sardegna in questo senso non è un’eccezione. Non siamo “speciali” nemmeno in questo, a dispetto dell’etichetta che ci piace tanto appiopparci da soli.
Il problema è che questo processo così profondo e strutturale delle relazioni politiche e culturali tra Sardegna e Italia ha condotto ad avere, anche in età repubblicana e autonomista, una classe politica orientata ad assecondare i disegni e gli interessi imposti dalle proprie case madri partitiche e sociali d’oltre Tirreno, o comunque a destreggiarsi tra la necessità di gestire la situazione nell’isola da un lato e la promozione delle proprie carriere e del proprio status personale e familiare dall’altro. Le élite isolane, dalla sconfitta della Rivoluzione sarda in poi, hanno svolto un ruolo di intermediazione, insomma, più che di leadership: controllare la situazione e non far emergere in piena luce il conflitto con lo Stato centrale, più che far emergere i nodi e cercare di scioglierli.
Per giunta, se fino alla fine della Guerra fredda le dinamiche politiche e la robustezza delle formazioni intermedie, prima di tutto i partiti, consentivano una certa selezione del personale politico, da trent’anni a questa parte, al problema strutturale della subalternità si è aggiunto anche un progressivo peggioramento della sua qualità complessiva. Oggi ci ritroviamo una Presidente della RAS che, nel marasma della mobilitazione generalizzata contro la speculazione energetica, dichiara di doversi preoccupare degli interessi degli “investitori” e che, davanti al sostegno diffuso e certificato a una proposta di legge di iniziativa popolare, proclama senza tremare e senza che nessuno reagisca che “i legislatori sono loro”, confondendo il ruolo del potere esecutivo e quello del potere legislativo, con tanti saluti allo Statuto regionale, alla Costituzione più bella del mondo e a tre secoli di riflessione politico-filosofica.
Non disporre di un ceto politico all’altezza è un gravame insostenibile, davanti alle sfide cui deve far fronte la Sardegna in quest’epoca difficile.
Poteva – e può – andare diversamente?
Non è un destino ineluttabile. Altre realtà territoriali, non necessariamente più avvantaggiate della Sardegna, sono riuscite a districarsi bene nella palude dello Stato italiano contemporaneo e a sfruttare le prerogative conquistate con battaglie politiche lungimiranti. Penso soprattutto alle due Province autonome di Trento e Bolzano (che conosco direttamente), il cui esempio è fin troppo imbarazzante per la politica sarda. Al di là delle differenze geografiche e storiche e delle rispettive peculiarità, uno degli elementi distintivi più rilevanti è la propensione delle classi politiche locali.
Se è vero che le autonomie trentina e sud-tirolese sono in partenza più robuste, anche in termini statutari, è anche vero che questo risultato non è stato una concessione a buon mercato dello Stato centrale. Né l’autonomia è concepita come una misura di tutela e sostegno a compensazione di una condizione deficitaria (come sempre la Presidente Todde, interpreta, a torto, l’autonomia sarda), bensì è rivendicata in virtù di peculiarità storico-culturali che vengono fatte pesare nella relazione con lo Stato. Lascerei stare la faccenda di come il Süd-Tirol sia arrivato a conquistare il famoso “Pacchetto”, ossia la concessione di una robusta autonomia propria; fatto sta che la sua classe politica è riuscita a farne tesoro.
Una differenza fondamentale tra Trentino-Süd-Tirol e Sardegna è che chi fa politica nelle due province autonome concepisce come propria comunità di riferimento quella di provenienza e come obiettivi massimi quelli che può ottenere per il proprio territorio. Non c‘è una subalternità a centri decisionali esterni né la proiezione delle proprie carriere verso Roma, come massima meta finale. A Roma, sia dal Trentino sia dal Süd-Tirol, si mandano figure a fine corsa o personaggi di secondo piano, col mandato di rappresentare lì gli interessi del territorio di provenienza. Se per il Süd-Tirol c’è il vantaggio del dominio pressoché costante della SVP, che agevola questa dinamica, il Trentino offre un quadro molto più plurale e più assimilabile a quello sardo.
Ed eccoci qua
In Sardegna non siamo mai stati in grado di sfruttare la nostra rappresentanza a Roma né l’autonomia regionale, tanto più che abbiamo rinunciato anche a renderne operative diverse previsioni, data la mancanza storica di decreti attuativi. Ci siamo gingillati con diversivi fantasiosi, questo sì, con saltuarie enunciazioni di orgoglio “regionale” ferito e retoriche dichiarazioni annesse. Il culmine di questa modalità di distrazione dell’opinione pubblica è stata la trovata geniale (da geni del male, s’intende) della ”insularità in costituzione”, per altro ormai del tutto scomparsa dall’agenda politica e mediatica (come volevasi dimostrare).
Ma pensiamo alla vertenza entrate, riscoperta in queste settimane dalla giunta Todde, dopo che nel ventennio precedente ogni giunta succedutasi a Cagliari ha annunciato di averla risolta. Anche questa è una partita in cui non c’entrano nulla pretese tare ancestrali della popolazione sarda, o presunti svantaggi geografici, o altri stereotipi degradanti di cui si nutrono la nostra subalternità e il nostro dipendentismo politico. Non c’entrano nemmeno pretesi vincoli legislativi insuperabili o l’adesione obbligata a una “lealtà istituzionale”, sempre richiamata e applicata in Sardegna e mai rispettata a Roma.
Caso mai si può serenamente parlare di “lealtà di partito” dei politici sardi verso le loro leadership italiane di riferimento. È questione di coscienza e di volontà, entrambe orientate non verso l’isola e chi la abita me verso tutt’altro. Per altro, a questo problema e alla mediocrità generale del ceto politico sardo si somma ormai da tempo il suo aperto disprezzo per la democrazia. In Sardegna, uno dei fallimenti storici dell’autonomia è stato proprio il mancato radicamento di una vera e consapevole sensibilità democratica, a tutti i livelli. Centralismo, clientelismo, assistenzialismo non sono magagne casuali e dovute a un destino malevolo.
C’è voluto del lavoro per tradurre le istanze di emancipazione e la volontà di partecipazione popolare in passiva rassegnazione alla prepotenza dei vari boiardi locali. Nei momenti in cui si è manifestato qualche rigurgito di insofferenza popolare, lo si è liquidato con mezzi discutibili, con forme di corruzione, cooptazione, col divide et impera. L’ostilità contro la democrazia reale a volte è mascherata con dosi tossiche di paternalismo verso i ceti popolari e verso le istanze sociali che emergono fuori dallo spettro limitato del Consiglio regionale. Ma poi, a conti fatti, le porte della rappresentanza istituzionale restano chiuse e il filtro a idee e prospettive realmente alternative è a maglie fittissime. Ne fa fede, in termini formali e anche simbolici, l’assurda legge elettorale regionale tutt’ora vigente, a dispetto dei proclami da campagna elettorale.
In conclusione
Il declino della Sardegna è già in atto. Il fatto di non disporre di una classe politica e nel complesso di un ceto dirigente all’altezza, sia come qualità sia come consapevolezza del proprio ruolo, ci espone al disastro più completo. Basteranno le mobilitazioni di questi ultimi anni e mesi per creare uno scenario diverso? Non lo so. Non è facile. Di sicuro non possiamo cedere alla rassegnazione, nonostante le pressioni e le difficoltà oggettive. È però importante non tacere sulla radice dei problemi e sulle responsabilità storiche di chi ha avuto e ha oggi ruoli decisionali rilevanti. Dopo di che, si tratta di fare ognuno/a la propria parte.
Immagine: italiaoggi.it
Un commento
Lascia un commento / Cummenta
I commenti saranno sottoposti ad approvazione prima della pubblicazione.
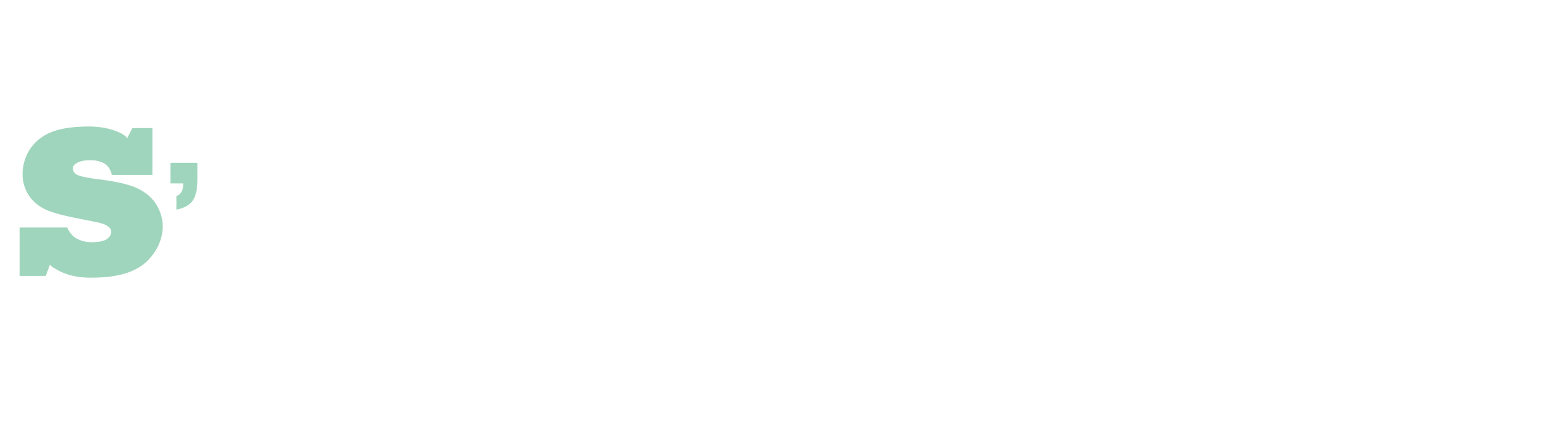


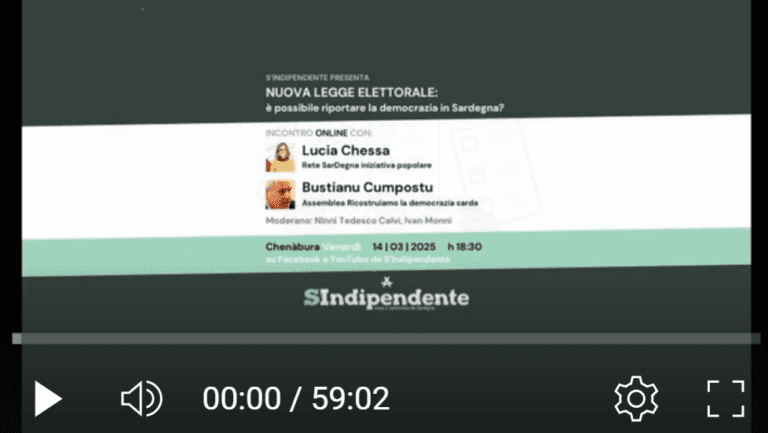













La mancanza di un partito sardo, non legato ai partiti italiani è la spia perennemente accesa che configura la nostra subalternità. Se si votano persone la cui dubbia, molto dubbia, propensione a risolvere i problemi dell’isola sono scritte sul relativo curriculum e che per di più sono legate o incatenate allo stato colonialista, di che cosa ci si può meravigliare? Quando un sardo vota per la lega o per i 5 stelle o, peggio, un partito sardo addirittura si unisce ad un partito d’oltremare, quale speranza possono avere i Sardi? E’ come cercare che di convincere una persona che, con tutte le bombe che esplodono per le guerre che ci sono in europa e dintorni forse, ed rimarco forse, la tua “vecchia” auto euro5 non incide più di tanto sul “cambiamento climatico”. E’ come ricordare alle persone che tante pale eoliche significano bilanciare i “crediti green” delle aziende d’oltremare (e non solo) che così possono continuare a inquinare. Ma i sardi hanno tutti l’Alzheimer e si ricordano solo di quanto fosse bravo Gigi Riva (ma solo per le reti fatte e non per la persona “omini balente” quale era).