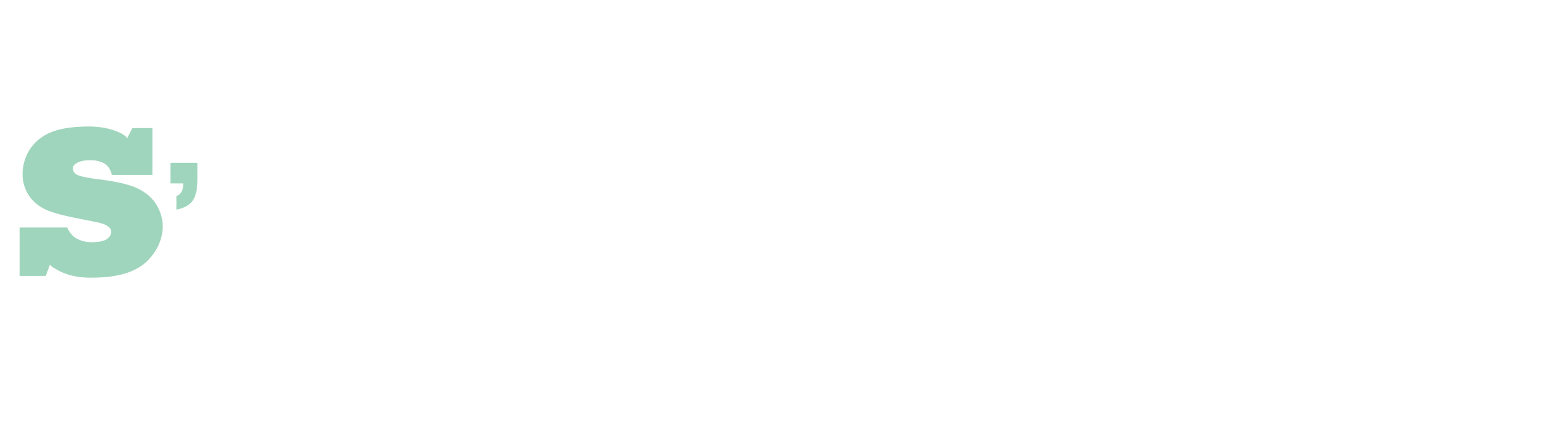4 novembre: anniversario della vittoria. Ma vittoria di chi e di che?
Ieri, 4 novembre, l’Italia ha vissuto una “giornata celebrativa nazionale”. Ricorreva, infatti, la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale, evento bellico considerato completamento del processo di unificazione risorgimentale, visto che permise all’Italia l’annessione di Trento e Trieste. Il 4 novembre è la data dell’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti (firmato il 3 novembre 1918), che sancì la resa dell’Impero austro-ungarico all’Italia.
In questo contributo, Francesco Casula si interroga sul perché si festeggi “una inutile strage”.
De Francesco Casula
Anche quest’anno, il 4 novembre, si sono scatenate le fanfare della retorica patriottarda e militarista con eventi, manifestazioni, raduni d’arma, conferenze e cerimonie solenni in molte città italiane: forse un po’ sottotono, ma esclusivamente a causa del Covid. E comunque senza alcun pudore. Infatti, non c’è proprio niente da celebrare e tanto meno festeggiare alcuna vittoria. Infatti: vittoria di che e di chi?
Quella guerra fu semplicemente “una inutile strage” – come la definì il Papa Benedetto XV (Nota ai capi dei popoli belligeranti del 1° agosto 1917, pubblicata in lingua francese) – e (in una enciclica del 1914, Ad Beatissimi Apostolorum Principis) una gigantesca carneficina. Rappresentò – è il grande storico Enzo Gentile, a scriverlo – “oltre che il tramonto della Bella Epoque, il naufragio della civiltà moderna. Una guerra nuova, completamente diversa da quelle fino ad allora combattute: per l’enormità delle masse mobilitate, per la potenza bellica e industriale impiegata, per l’esasperazione parossistica dell’odio ideologico” [1].
Mentre per lo scrittore austriaco Joseph Roth, cantore della Finis Austriae, la guerra rappresentò per il mondo “un cumulo di macerie” (La cripta dei Cappuccini). Una guerra – scrive Freud – “che ha rivelato, in modo del tutto inaspettato, che i popoli civili si conoscono e si capiscono tanto poco da riguardarsi l’un l’altro con odio e con orrore” [2].
Una vera e propria catastrofe annientatrice d’ogni forma di vita e civiltà, trasformate in cumuli di rovine: riducendo l’Europa a “un’oasi estinta e sterile” scrive il tedesco Ernst Jünger, “dove non c’è segno di vita per quanto lontano possa spingersi lo sguardo e sembra che la morte stessa sia andata a dormire” [3].
Con centinaia di città sistematicamente distrutte, completamente cancellate dalla faccia della terra. Ma, soprattutto, con un ingentissimo numero di soldati sacrificati inutilmente: la sola Italia ebbe 650 mila morti e 2 milioni tra feriti e mutilati.
E insieme alla carneficina di vite umane, la devastazione e distruzione della natura. A descriverla in modo suggestivo è il romanziere francese Henri Barbusse, combattente sul fronte occidentale, che parla del “nuovo mondo” costruito dalla guerra nel Continente europeo: “un mondo di cadaveri e di rovine” terrificante, pieno di marciumi, terremotato” [4].
Ma c’è di più: nuove e ancor più drammatiche conseguenze si profilavano all’orizzonte con la fine dei combattimenti e il Trattato di Versailles. Con il ridisegno dell’intera geografia europea secondo la volontà dei vincitori, si ponevano le premesse per altre tragedie: la corsa al riarmo e la militarizzazione di massa della società saranno alla base dei regimi totalitari come il fascismo e il nazismo.
I 650 mila morti e i più di 2 milioni di feriti e di mutilati erano costituiti soprattutto da contadini, operai e giovani mandati al macello nelle trincee del Carso, sul Piave, a Caporetto e nelle decimazioni in massa ordinate dagli stessi generali italiani. Carne da macello fornita soprattutto dai meridionali siciliani, calabresi, campani, lucani e sardi, mentre i settentrionali per lo più erano produttivamente impegnati nelle fabbriche di armi e di cannoni.
Sardi soprattutto, almeno in proporzione agli abitanti: alla fine del conflitto la Sardegna avrebbe infatti contato ben 13.602 morti (più i dispersi nelle giornate di Caporetto, mai tornati nelle loro case). Una media di 138,6 caduti ogni mille chiamati alle armi, contro una media italiana di 104,9.

E a “crepare” saranno migliaia di pastori, contadini, braccianti chiamati alle armi: i figli dei borghesi, proprio quelli che la guerra la propagandavano come “gesto esemplare” alla D’Annunzio o, cinicamente, come “igiene del mondo” alla futurista, alla guerra non ci sono andati.
La retorica patriottarda e nazionalista sulla guerra come avventura e atto eroico va a pezzi. Abbasso la guerra, “Basta con le menzogne” gridavano, ammutinandosi con Lussu, migliaia di soldati della Brigata Sassari il 17 gennaio 1916 nelle retrovie carsiche, tanto da far scrivere in Un anno sull’altopiano allo stesso Lussu: Il piacere che io sentii in quel momento, lo ricordo come uno dei grandi piaceri della mia vita.
In cambio delle migliaia di morti, – per non parlare delle migliaia di mutilati e feriti – ci sarà il retoricume delle medaglie, dei ciondoli, delle patacche. Ma la gloria delle trincee – sosterrà lo storico sardo Carta-Raspi – non sfamava la Sardegna.
Sempre Carta Raspi scrive: ”Neppure in seguito fu capito il dramma che in quegli anni aveva vissuto la Sardegna, che aveva dato all’Italia le sue balde generazioni, mentre le popolazioni languivano fra gli stenti e le privazioni. La gloria delle trincee non sfamava la Sardegna, anzi la impoveriva sempre di più, senza valide braccia, senza aiuti, con risorse sempre più ridotte. L’entusiasmo dei suoi fanti non trovava perciò che scarsa eco nell’Isola, fiera dei suoi figli ma troppo afflitta per esaltarsi, sempre più conscia per antica esperienza dello sfruttamento e dell’ingratitudine dei governi, quasi presaga dell’inutile sacrificio. Al ritorno della guerra i Sardi non avevano da seminare che le decorazioni: le medaglie d’oro. d’argento e di bronzo e le migliaia di croci di guerra, ma esse non germogliavano, non davano frutto” [5].
C’è da festeggiare per questo dramma immane? Magari spendendo soldi in parate militaresche? No, non c’è niente da festeggiare.
Foto de presentada: Maruf Bijoy da Pexels
Note bibliografiche
[1]. Enzo Gentile, L’Apocalisse della modernità, Mondadori, Milano, 2009, pagina 17.
[2]. S. Freud, Considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte, trad. it. Carlo Musatti e altri, Torino, 1989, pagine 30.
[3]. E. Jünger, Boschetto 125, trad. it. Di A. Iaditiccio, Parma 1999, pagina 28.
[4]. Henri Barbusse, Il Fuoco, trad. italiana di G. Bisi, Milano, 1918, pagina 218.
[5]. Raimondo Carta-Raspi,Storia della Sardegna, Ed. Mursia, Milano, 1971, pagina 904).