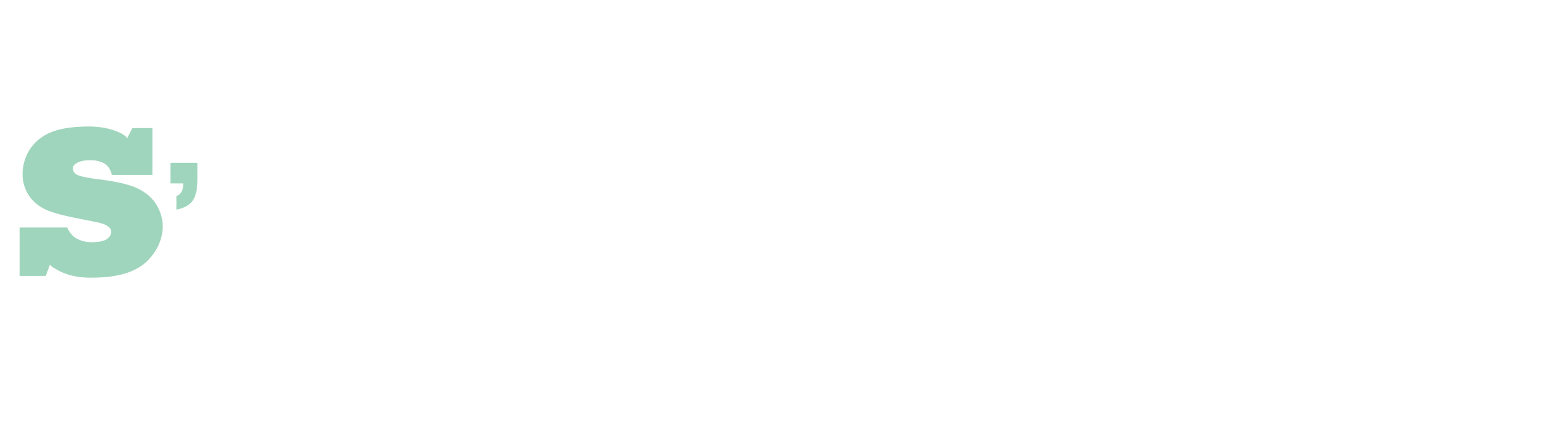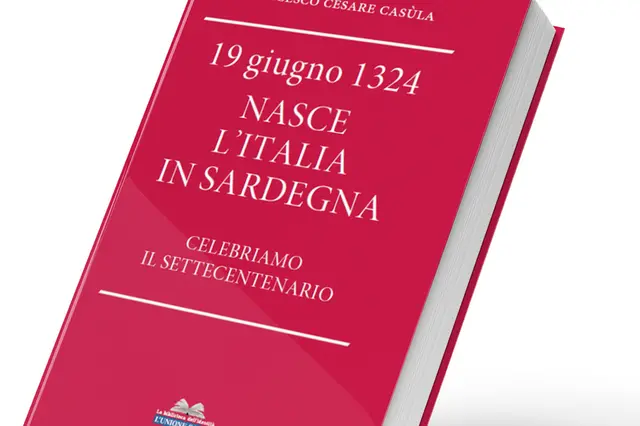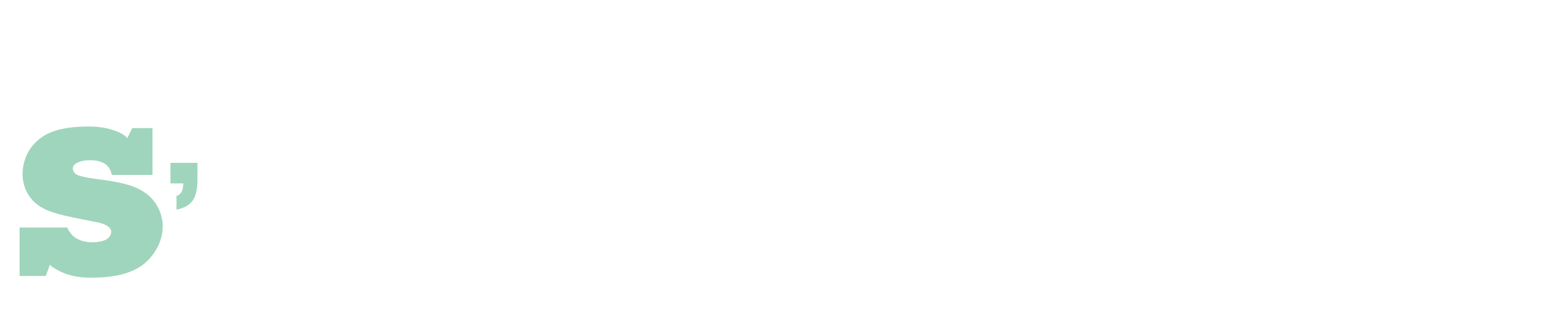de Omar Onnis
Il 19 giugno ricorre il 55esimo anniversario della rivolta di Pratobello, a Orgosolo, momento culminante di un periodo di mobilitazione popolare e di resistenza “informata” e consapevole ai soprusi del governo italiano (ne abbiamo parlato qui).
Sorprendentemente, l’Unione sarda decide invece di celebrare tale data con l’uscita di un libello dedicato alla conquista catalano-aragonese di Castel di Calari (Cagliari). O meglio, alla fondazione della testa di ponte di Bonaria, avvenuta, secondo le cronache, proprio il 19 giugno del 1324 (la rocca di Castel di Calari sarebbe stata conquistata solo due anni dopo). La ragione sta nella singolare tesi storica di Francesco Cesare Casula, autore del libello, secondo la quale lo stesso stato italiano attuale sarebbe nato proprio lì, sul colle di Bonaria, quel 19 giugno di settecento anni fa.
L’idea di fondo è la seguente: dato che lo stato italiano attuale discende direttamente dal Regno di Sardegna e il primissimo nucleo del Regno di Sardegna – creato sulla carta da Bonifacio VIII tra 1295 e 1297 – fu realizzato dai catalano-aragonesi con l’allestimento di quel campo fortificato, ecco che si può trarne la conclusione lineare che lo stato italiano sia nato lì, in quel giorno.
Ora, la tesi di F.C. Casula non è affatto nuova. Chiunque abbia studiato storia medievale nell’ateneo cagliaritano tra anni Ottanta e anni Novanta del secolo scorso ha avuto a che fare con la sua “dottrina della statualità”. Casula ha anche provato a proporla nel consesso degli studi storici italiani, venendone respinto con perdite. Non che il consesso degli studi storici italiani sia il non plus ultra. Diciamo che a livello internazionale è piuttosto marginale e poco considerato. L’ambito storiografico sardo è periferico e negletto anche rispetto a quello italiano. E con questo mi pare che non ci sia altro da aggiungere.
In Sardegna, la tesi di Casula rispunta fuori di tanto in tanto, a cadenza irregolare ma non meno implacabile. Sarebbe interessante capire il perché. In ogni caso, a mio avviso si tratta di una tesi piuttosto discutibile, per non dire totalmente infondata. Lo è sul piano storico e lo è sul piano politico-ideologico.
Sul piano storico soffre di diversi problemi. Intanto c’è un anacronismo evidente nel far retroagire su un episodio tutto sommato minore di una vicenda ben più complessa (la guerra per l’egemonia nel Mediterraneo occidentale, la lotta per il potere tra papato, impero e regni vari, le complicate vicende tra Regno di Aragona catalano e regno di Arborea) un esito molto più tardo (la creazione dello stato unitario italiano). Inoltre, le argomentazioni formali (e formalistiche) addotte da Casula si scontrano non solo con la lunghezza e la notevole articolazione interna di una storia come quella sarda, tra tardo Medioevo e Età contemporanea, ma anche col dato storico e giuridico della fine di fatto e di diritto del Regno di Sardegna nel 1848.
Nel 1848, con l’entrata in vigore della Perfetta Fusione e dello Statuto albertino, il Regno di Sardegna finisce di esistere, benché ne rimanga in vita il nome. Quando nel marzo 1861 quel nome muta in Regno d’Italia, del vecchio Regno sardo non c’è già più nulla da un pezzo. Quindi non esiste alcuna continuità diretta e lineare tra quello che le forze aragonesi guidate dall’Infante Alfonso fecero sul colle di Bonaria il 19 giugno 1324 e l’unificazione italiana.
Sul piano politico e ideologico c’è da chiedersi perché mai in Sardegna dovremmo celebrare il primo atto di una guerra di conquista che avrebbe infine visto l’isola soccombere alla monarchia aragonese e al suo regime feudale (questo sì una disgrazia storica). Che da quella conquista – sanguinosa e costosa per entrambe le parti – possa essere in qualche modo derivato lo stato italiano attuale, dentro il quale non siamo che una porzione periferica, marginale e per troppi versi coloniale, non sarebbe comunque un esito da celebrare.
Il nazionalismo sardo-italiano, una costante della nostra storia recente, è un fattore deleterio rispetto alla nostra condizione materiale. L’ottuso centralismo che ne è un effetto diretto, a cui la politica sarda non ha mai saputo opporsi decentemente, nonché il sostrato razzista anti-sardo su cui si fonda dovrebbero renderlo inviso a chiunque abbia a cuore la dignità e le possibilità di emancipazione collettiva della popolazione isolana.
Ma anche dando per fondata la tesi di Casula, se pensiamo a cosa ha combinato lo Stato italiano da che esiste (cioè, esagerando, dal 1848), non ci sarebbe proprio nulla di cui vantarsi: colonialismo esterno e interno, fascismo, strategia della tensione, Mani Pulite, ecc. ecc. O davvero vogliamo intestarci – abusivamente, ma con la solita esagerata enfasi dei subalterni – gli elementi che denotano l’italianità? Mi riferisco alle solite argomentazioni che chiamano in causa la Romanità, il Rinascimento, il Risorgimento, ecc. ecc., fino alla santa e “più bella del mondo” costituzione repubblicana.
Enfatizzare il 19 giugno 1324, data insignificante e tutt’al più esecrabile, al posto della ricorrenza della lotta di Pratobello potrebbe essere solo una caduta di stile, o una scelta ottusa, o invece potrebbe essere una presa di posizione politica deliberata. Non lo sappiamo. Non è chiaro a cosa serva alimentare ancora la nostra subalternità culturale e il nostro costante complesso da figli di un dio minore della storia. O forse è fin troppo chiaro. In ogni caso è doveroso opporre a tale narrazione ideologicamente orientata tanto la correttezza storica quanto delle robuste obiezioni politiche.
Immagine: Unione Sarda